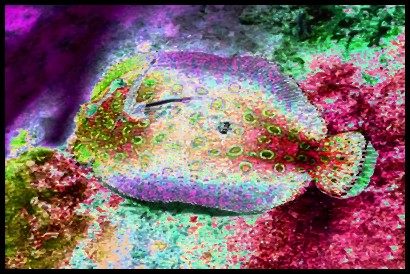Platani e querce secolari torreggiavano sopra la minuta figura di Mishan, cacciatore delle marche di ponente, ricordandogli le antiche leggende. La foresta era sempre stata lì, prima che l’uomo mettesse piede sul continente, prima che le navi lasciassero le sponde dell’Impero Caduto, e molto prima che le antiche guerre scoppiassero e gli uomini dimenticassero di essere stati tutti fratelli.
Platani e querce secolari torreggiavano sopra la minuta figura di Mishan, cacciatore delle marche di ponente, ricordandogli le antiche leggende. La foresta era sempre stata lì, prima che l’uomo mettesse piede sul continente, prima che le navi lasciassero le sponde dell’Impero Caduto, e molto prima che le antiche guerre scoppiassero e gli uomini dimenticassero di essere stati tutti fratelli.Se il tempo era nemico di ogni cosa viva, animali, piante e uomini, la foresta, che il suo popolo aveva sempre chiamato Uaki, il Grande Respiro, non sembrava venire scalfita dal deteriorante rintocco dei secoli. Eppure c’era qualcosa di strano in quel verde così rigoglioso e in quell’abbondanza di foglie, fiori e frutti. Mishan non aveva mai visitato i lidi di Uaki prima di allora, ma subito capì che l’ultima guerra, quella devastante venuta dal nord, era riuscita a trasformare anche quel luogo. Infatti, anche se le piante sembravano esplodere di vitalità, come fossero soggette ad una perenne primavera, nell’aria alitava un odore malsano. A Mishan fece pensare al fetore della decomposizione, il tipico tanfo dei sepolcri e dei luoghi dei morti. Quelle due così distanti sensazioni, vista e olfatto, percepite insieme, mettevano i brividi.
Mishan ricordò perché era giunto fino alla foresta. La mente andava distratta quando le paure più inspiegabili affioravano in superficie. Per due interi mesi aveva viaggiato attraverso le montagne del remoto occidente, terre di lupi e di orsi. Era il rituale ultimo che il suo popolo chiedeva a coloro i quali desideravano diventare Grandi Cacciatori. Mishan aveva affinato le sue tecniche di caccia e di sopravvivenza ed era finalmente pronto a ricevere l’investitura.
Ma la guerra era arrivata d’improvviso, una moltitudine di guerrieri corazzati e assetati di sangue proveniente dal grande nord. Nessuno si era capacitato del perché quei popoli solitamente pacifici, si erano uniti e avevano mosso guerra alle terre del sud. Qualcuno aveva già intessuto una leggenda al riguardo. Sembrava che una creatura millenaria, imprigionata nei remoti ghiacciai settentrionali, a causa delle alte temperature della passate estate, era stata liberata. In pochi giorni, richiamando un potere oscuro, la creatura aveva soggiogato le menti dei biondi e valorosi uomini del nord, per guidarli in una folle campagna di morte. Per questo motivo era stata chiamata la Guerra della Follia.
Tutto questo Mishan lo aveva saputo al suo ritorno, interrogando i pochi sopravvissuti che aveva incontrato lungo la strada. Il suo popolo era stato costretto ad abbandonare le sue terre e a salpare verso l’arcipelago di Matiki, nei mari del sud. Sconvolto da quelle notizie, Mishan aveva deciso di partire per le marche d’oriente, dove si diceva che la guerra avesse sterminato intere popolazioni.
Giunto ai confini della foresta, si era augurato di incontrare gli elfi, il popolo magico che da sempre abitava quei lidi. Non poteva credere che anche loro fossero stati spazzati via dalla furia dei popoli del nord. Ma inoltrandosi dentro Uaki, avvertì una spaventosa solitudine. Non solo non vi erano tracce degli elfi, ma anche gli animali della foresta parevano scomparsi. E proprio l’inusuale silenzio, rotto solo dal muoversi delle frasche al vento, era la terza strana sensazione che non poteva ignorare. Tutto ciò lo rendeva molto inquieto.
“Ma che fine avranno fatto i folli guerrieri del nord?” si chiese per l’ennesima volta. Nessuno lo sapeva. Sembrava che l’entità che si era liberata dal ghiaccio perenne, non avesse uno scopo di conquista. L’unico suo interesse era quello di distruggere. Mishan si era imbattuto in almeno due grandi campi di battaglia, disseminati da corpi putrefatti e armi incrostate di sangue, e non aveva visto neanche un vessillo. Era come se le armate del nord non fossero state mosse da alcun desiderio di occupazione.
Il sole si stava abbassando. Era una di quei tiepidi pomeriggi di fine estate, e le giornate di stavano rapidamente accorciando. Malgrado tutti i pensieri che gli vorticavano nella testa, Mishan non poté fare a meno di storcere il naso per via di quell’odore. E più s’inoltrava all’interno della foresta, più diventava insopportabile.
L’iniziazione lo aveva formato definitivamente. Un uomo né alto né robusto, ma in completo controllo di ogni centimetro del suo corpo. Vestiva le pelli dei lupi e degli orsi, ma erano solo ornamenti per i suoi muscoli, che affioravano nudi e lucidi in tutta la loro avvenenza. Portava un arco lungo legato dietro la schiena e un’accetta da battaglia, piccola e fatale, arma rituale del suo popolo. Gli occhi erano allenati a captare i movimenti più sottili e a prevedere gli inganni dei paesaggi uniformi. Sulla neve tutto può succedere…
Mishan si arrestò nel mezzo al sentiero. Nessun rumore, nessun movimento, solo una strana, stranissima sensazione. Qualcuno o qualcosa lo stava osservando. Aguzzò la vista, cercando tra i riverberi della rugiadosa vegetazione. Le piante non avevano occhi, ma potevano nascondere il tuo peggior nemico…
Non era uno solo. Sentiva che erano tanti, che erano troppi. Rimase immobile ascoltando il suo respiro, controllando la paura. Le nocche gli si sbiancarono mentre stringeva il manico dell’accetta. Ma non poteva sperare di farcela da solo. Aveva bisogno di pensare, di capire, di vedere…
Una creatura bianca e glabra dalla forma vagamente umana fuoriuscì dalla foresta e lentamente, con un movimento eretto ma in qualche modo strisciante, si avvicinò a lui. Mishan intuì che ve n’erano decine di simili creature dietro gli alberi dai quali era comparsa quella. Restò fermo ma il braccio era pronto a scattare.
L’essere aveva la corporatura di un bambino con gli arti leggermente più lunghi e sottili, mani anch’esse lunghe e affusolate, ed era completamente nudo, ma privo di un riferimento sessuale. Il volto era senza bocca e aveva due orifizi per naso. Gli occhi si distinguevano appena in quella maschera lattiginosa, mentre gli orecchi erano piccoli e a punta, proprio come si diceva fossero quelli degli elfi.
Silenziosa e cauta, la figura opalescente si mise ad osservare il cacciatore, girandogli intorno, avvicinando la faccia alle sue membra come se volesse annusarlo. Il rituale andò avanti per qualche minuto, mentre Mishan rimaneva immobile come un cobra davanti alla preda.
Poi l’essere indietreggiò, sempre col suo fare strisciante, tornò da dove era venuto ma non dette mai le spalle al cacciatore. Continuò a fissarlo camminando all’indietro come un gambero, per poi dileguarsi tra la vegetazione. Mishan lasciò passare qualche minuto e poi il suo sesto senso lo avvertì che le creature se n’erano andate, e non vi era più pericolo. Così riprese il cammino.
Il bizzarro incontro lo convinse che non sarebbe stata una buona idea rimanere nella foresta per la notte. Ma ormai le ombre della sera si stavano preparando a fare il loro ingresso sul mondo, e neanche correndo indietro con tutte le sue forze sarebbe mai riuscito ad uscire prima del tramonto. Ricordava però di un fiume, segnato sulle vecchie mappe del capo villaggio. Quando era bambino adorava perdersi tra le righe sottili di quei quadri ingialliti, che indicavano terre misteriose e lontane. Asekor era chiamato nella sua lingua, il grande fiume meridionale, che nascendo dai ghiacci perenni viaggiava per centinaia di miglia verso sud, tagliando in due la foresta, e riversandosi infine nel grande mare. Se fosse riuscito a raggiungere le sue sponde, avrebbe avuto una via di fuga, nel caso le creature fossero ricomparse. Mishan era un abile nuotatore, e aveva la sensazione che quegl’esseri bianchicci non amassero l’acqua.
Allungò il passo, mentre la luce da bianca diventava gialla e poi arancione. Il fetore continuava a tormentarlo, ma ad un certo punto diventò più sopportabile, gli alberi persero quel rigoglio così innaturale e con suo grande sollievo udì il cinguettare di alcuni uccelli. La foresta sembrava nuovamente viva, ma Mishan non riusciva a capire perché. Quando finalmente percepì l’inconfondibile odore del fiume, comprese la ragione di quella trasformazione. Vicino ad Asekor, la foresta era ancora quella di sempre.
Il sole si spense nel remoto occidente, ma nel riverbero vespertino Mishan alzò un riparo per la notte. Si piazzò sulla riva del grande fiume, che a quell’altezza raggiungeva un larghezza di almeno duecento metri. L’immensa massa d’acqua, alimentata dai recenti temporali estivi, procedeva lentamente trasportando rami e detriti. Il cacciatore consumò una cena fredda e cercò un sonno leggero, quello tipico dei lupi solitari, che non possono permettersi compagni di viaggio che montino la guardia. Al minimo rumore sarebbe scattato in piedi, pronto a colpire.
Ma c’era una cosa che Mishan ignorava. Il fiume era ancora più antico della foresta, e conservava un segreto che trascendeva il tempo stesso, o almeno il tempo nel modo in cui gli uomini lo percepiscono. Il sonno lo rapì come un bambino, e viaggiò nei mondi di lato, osservando il vero ed il falso, la realtà e il sogno. Si svegliò ma stava ancora dormendo, e credendosi desto incontrò il Re del Fiume.
La foresta era giovane e il fiume scorreva lento. Un mattino di sole abbagliante, la rugiada fresca e gli uccelli nel cielo. Mishan guardò la figura avvicinarsi, un vecchio dal volto gentile con lunghi capelli lisci e scuri. Si accomodò di fronte a lui e incominciò a narrare una storia, ma come succede spesso nei sogni, pur volendo domandare o ribattere Mishan non riuscì a farlo. Rimase immobile davanti al vecchio ad ascoltare.
“Hai fatto la cosa giusta a venire da me. Io stanotte potrò proteggerti, ma domani riparti subito e lasciati alle spalle la foresta, perché anche se può sembrarti splendida e rigogliosa, sappi che in realtà è già morta. Esistono cose che si credono vive in eterno, ma che in realtà altro non sono che accanimenti alla vita. Gli elfi hanno abitato questi lidi per millenni e hanno creduto che ci sarebbero rimasti per sempre. È pur vero che la percezione del tempo per il popolo della foresta è oltremodo dilatata, ma anche per loro esiste un inizio e una fine. Kratoa, l’essere che ha mosso guerra a tutte le terre del sud, è stato l’avvento della loro fine. Non esistono spiegazioni che un uomo possa facilmente accettare. La vita è ciclica. Esistono stagioni di nascita, come la primavera, e stagioni di morte, come l’inverno. Gli elfi credevano in un estate imperitura, e si sbagliavano. Ma hanno rifiutato di scegliere di lasciare queste terre per un nuovo mondo, e come conseguenza sono rimasti prigionieri di questo. Né vivi, né morti, in una foresta che si crede viva ma puzza di morte. Fuggi uomo, e racconta questa storia, perché la gente sappia che la foresta è diventata malvagia, e solo il grande fiume ne ricorda ancora lo splendore. Addio!”
Mishan si svegliò e finalmente comprese che stava sognando, eppure quel sogno era in qualche modo più vero degli altri. Raccolse le sue cose e seguì il consiglio del Re del Fiume. Tornò velocemente sui suoi passi e prima che il sole fosse alto già era in vista delle praterie oltre la cintura di alberi secolari che delimitavano Uaki.
Volse lo sguardo verso la foresta prima di riprendere il cammino e lasciarsela definitivamente alle spalle. Gli sembrò di vedere una figura lattiginosa attraversare il sentiero che aveva appena percorso. Un brivido gli corse lungo la schiena. “La foresta vampira” pensò.
E da allora la gente la chiamò così.